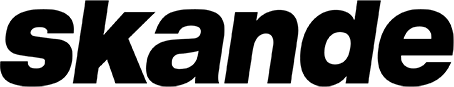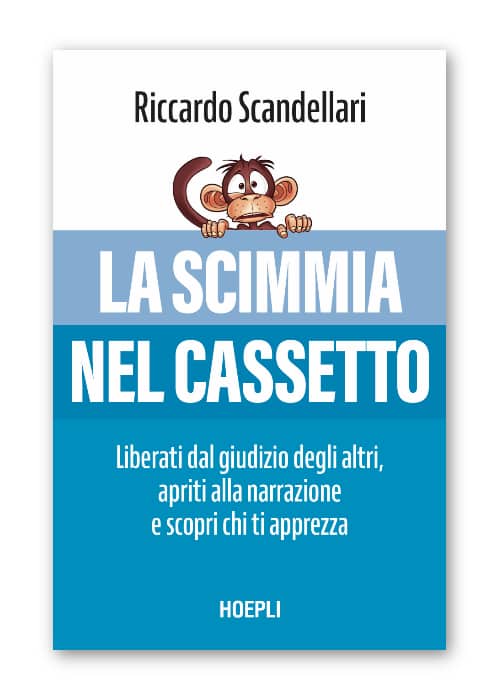Era una mattina grigia, con la pioggia che batteva piano sul ciottolato di Ferrara, quando ho rivisto Matteo. Camminava senza nessuna fretta, e l’ho riconosciuto subito: un evento più unico che raro, dato che, in quanto a fisionomie, sono sempre stato un disastro.
Ci siamo abbracciati come si fa con chi ha condiviso una parte del proprio passato. Erano trascorsi vent’anni dall’ultima volta in cui ci eravamo parlati.
All’inizio degli anni Duemila era partito per Roma, lasciandosi alle spalle l’umidità tipica della zona, per fondare un’azienda nel settore cinematografico, dove ha ottenuto un discreto successo economico e professionale.
Mi sarei aspettato di vederlo diverso, non tanto nell’aspetto fisico, quanto nelle caratteristiche tipiche di chi ha raggiunto certi traguardi: abito di marca, orologio prestigioso, auto lussuosa. Invece era lì, esattamente come lo avevo lasciato, con gli stessi jeans troppo stretti.
Il successo l’ha investito altrove: oggi è riuscito, all’età di cinquant’anni, a realizzare quello che per molti è un sogno, ovvero un F.I.R.E. (Financial Independence, Retire Early); in poche parole, una sorta di “pensione” autofinanziata grazie alle risorse che ha accantonato vendendo la sua società. Mi ha portato a una riflessione: i nostri nonni, oppure i nostri genitori, avrebbero mai fatto una scelta del genere? Un passo indietro verso una vita più lenta?
Unstatus?
Nelle epoche passate, lo status era qualcosa di immediato, semplice e visibile: il vescovo, il cavaliere, il nobile. Quasi sempre lo si otteneva alla nascita.
L’era industriale ha rimescolato le carte, assegnando prestigio anche alla ricchezza: l’imprenditore, la rockstar, il politico.
L’era digitale ha fatto un ulteriore salto, introducendo status legati alla quantità di connessioni, alla rilevanza comunicativa e al posizionamento di brand personale.
Oggi, però, i simboli classici – ville, auto di lusso, abiti firmati – stanno perdendo attrattiva, specie tra le nuove generazioni. Ovviamente non sono spariti, ma non godono più dello stesso rispetto unanime.
Basta osservare le élite urbane in città come Tokyo, New York o Milano: l’architetto che abbandona l’auto sportiva per i mezzi pubblici, il direttore creativo che veste in modo anonimo, o il top manager che esce da tutti i social.
Queste scelte non sono solo pratiche, ma segnano un cambiamento profondo: oggi lo status si misura sempre più in riservatezza, valori etici, equilibrio sostenibile e connessioni autentiche. Si premia ciò che ha un profondo significato per noi.
Da una sbornia di simboli e oggetti costosi da mostrare, ci stiamo lentamente incamminando verso un nuovo modo di essere in cui si appare meno ma si vive di più.
Oggi è incredibile pensarci, ma i social media hanno accelerato sia la competizione sia la sovversione dello status, e le persone si sono schierate da entrambi i lati.
Prendersi una pausa da Instagram, annunciare il proprio “digital detox” o mostrare quanto poco ci importi dei like sono diventati gesti carichi di significato.
L’indifferenza è la nuova forma di distinzione. Il vero status, paradossalmente, sembra appartenere a chi non sente più il bisogno di mostrarsi o, meglio ancora, di giustificare la propria assenza.
Ho ascoltato un’intervista a Dan Bilzerian, noto e controverso influencer americano, in cui descriveva la sua uscita dai social definendoli “un videogioco a cui ho giocato… e vinto, cinque anni fa”.
Abbiamo giocato anche noi a quel videogioco.
Forse non abbiamo mai davvero vinto, ma a un certo punto abbiamo smesso di contare le volte in cui si è solo perso tempo.